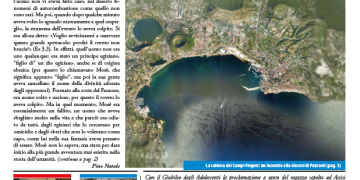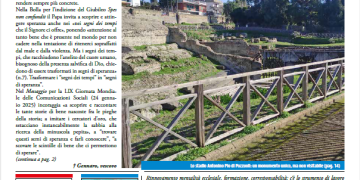Nascosta tra le ombre di un cortile signorile al Vomero, giace da tempo una statua togata femminile in marmo. Acefala, mutila, annerita dal tempo. Eppure, viva di storia. Si trova nel cortile monumentale di Villa Carafa di Belvedere (più nota semplicemente come Villa Belvedere), affacciata sul golfo di Napoli, accanto a una cancellata in ferro battuto e a due colonne in tufo d’ispirazione egizia. Potrebbe trattarsi di un rifacimento settecentesco (come l’esedra e altri fregi marmorei sulla strada d’accesso al portale), di moda all’epoca. Ma è suggestiva anche l’ipotesi di un reperto romano che potrebbe provenire da Pozzuoli, Cuma o forse da una necropoli lungo l’antica via Antiniana, il tracciato romano che univa Neapolis a Cuma, passante proprio per quest’area collinare.
La statua raffigura una matrona romana: veste una toga dal panneggio sottile, ha i calcei ai piedi (dettaglio raro), un bracciale inciso al polso destro e la mano delicatamente piegata sul petto. È priva del capo ma conserva una notevole forza plastica.
Se davvero romana (e comunque modelli simili di statue togate si possono ammirare al Museo Archeologico dei Campi Flegrei, al Castello di Baia), la datazione più probabile è tra la fine dell’età augustea e i primi decenni del I secolo d.C., epoca in cui le città flegree fiorivano di commerci, arte e cultura. Alla base, due fori laterali potrebbero indicare l’appartenenza a un gruppo statuario, forse una coppia funeraria, oppure essere frutto di interventi successivi.
Villa Belvedere, oggi in parte residenza privata, fu costruita nel Seicento dal banchiere fiammingo Ferdinando Vandeneynden, grande collezionista d’arte. Passò poi ai Carafa di Belvedere, che ne fecero una delle dimore più sontuose del Vomero, arricchita nel tempo da giardini, fontane e terrazze. Durante l’epoca borbonica, quando Ferdinando IV incoraggiava gli scavi a Pompei, Ercolano e Baia, molte ville aristocratiche si adornarono con reperti archeologici, spesso prelevati senza contesto e inseriti in scenografie romantiche, secondo il gusto neoclassico.
La statua potrebbe essere giunta in questo modo: sradicata dal suo luogo d’origine – forse un sepolcro lungo la via Antiniana – e trapiantata in un giardino nobiliare per ragioni estetiche.
Oggi, quel frammento di memoria è in stato di abbandono. Nessuna protezione, nessuna targa esplicativa, nessun censimento ufficiale. È un bene “fantasma”, come tanti altri dispersi tra cortili e giardini privati. Eppure, ha un forte valore storico, iconografico e simbolico: è l’immagine della donna romana onorata per le sue virtù civiche e familiari, testimone di un mondo in cui la memoria si scolpiva nella pietra.
Serve un intervento della Soprintendenza Archeologica per Napoli e i Campi Flegrei: una campagna di studio, attribuzione e tutela. Tra le proposte, il trasferimento proprio al Museo di Baia, dove potrebbe trovare nuovo significato nel contesto a lei più congeniale.
Restituire dignità a questa matrona togata significa restituirla alla collettività: ai cittadini, agli studiosi, agli studenti. Perché l’archeologia non è solo museo, ma anche scoperta quotidiana nei luoghi più insospettabili.